Don Luigi Pedussia
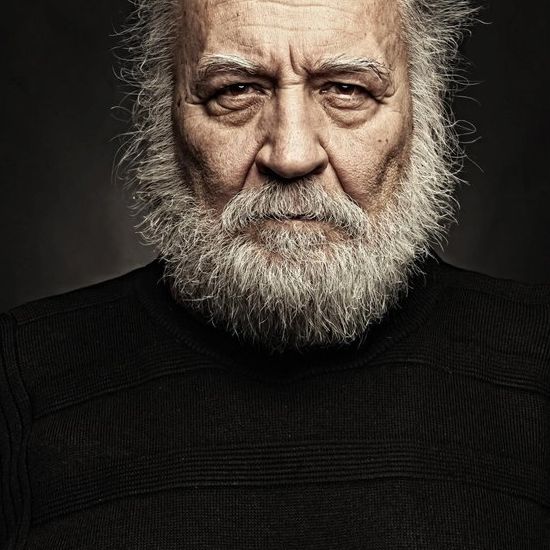
Ciascuno ha incise nel fondo della memoria alcune figure che emergono nitidamente e che l’usura del tempo non rende evanescenti, ma anzi fa apparire più vive e più simpatiche. Una di queste è la figura rubizza, dal mento un po’ aguzzo, di Don Luigi Pedussia, prete salesiano che a Volterra ha speso una buona parte della sua vita sacerdotale.
Pochissimi lo hanno ricordato: io che cominciai a conoscerlo agli inizi degli anni Trenta e che l’ho visto all’opera fino al momento della morte di Mons. Munerati, di cui era segretario, mi proverò a ricordarlo. Questa non sarà una biografia in senso normale del termine, ma piuttosto una serie di appunti, di ricordi, di impressioni forse non del tutto in perfetta cronologia. Ma forse Don Pedussia una biografia tradizionale non la vorrebbe nemmeno. Era assai schivo e molto modesto ed attribuiva tutto quello che di bello e di buono faceva al suo santo prediletto, Giovanni Bosco, fondatore dell’ordine a cui apparteneva.
Don Pedussia era nato nel 1881 a Carmagnola (in provincia di Torino) da una famiglia contadina che aveva molti figli. Ben presto entrò nell’ordine dei Salesiani e, ancora seminarista, ebbe il suo primo incontro con Dante Munerati, allora già sacerdote salesiano, ma non ancora vescovo.
Dante Munerati aveva bisogno di un giovane che fungesse da segretario per un certo periodo di tempo per certi suoi studi e ricerche che lo impegnavano molto. Gli fu assegnato, per caso, il giovane Pedussia, seminarista tenace, intelligente, attento, riflessivo e… testardo. Quando fu nominato vescovo di Volterra fece intendere alla sua congregazione che sarebbe andato a Volterra solo se gli avessero affidato come segretario Don Luigi Pedussia. Si iniziò così, tra i due, quel sodalizio che sarebbe durato per tutta la vita del vescovo. Per Don Pedussia fu inefficace, infatti, la prassi del suo ordine che, in genere, nel giro di sei anni trasferiva i sacerdoti da una casa all’altra. Il binomio vescovo Munerati – Don Pedussia sarebbe stato interrotto solo dalla morte.
Per dare volto ai due personaggi, fare riferimento alla foto in cima. Al centro, a partire da sinistra il vescovo Dante Maria Munerati e don Luigi Pedussia.
UN ORATORIO E TANTA GIOVENTÙ
Qui a Volterra Don Pedussia era destinato ad essere un prete in solitudine sacerdotale: ossia, i sacerdoti, in genere, non lo potevano soffrire. La solitudine per un prete non è cosa eccezionale, ma deve essere triste non legare con i confratelli. Tutto sommato, quando con la morte del Munerati Don Pedussia se ne andò da Volterra, moltissimi furono felici di liberarsene. Quel prete piemontese, tenace, attivo aveva turbato il quieto vivere di tanta gente pastoralmente o arretrata o addormentata. Centinaia di volterrani, allora ragazzi, ricordano con simpatia ed affetto questo prete della loro fanciullezza ed adolescenza. Quasi nessun prete lo ha amato o lo ha ricordato o lo ricorda con simpatia.
Don Pedussia a Volterra non si limitò, infatti, a fare il segretario del vescovo ma, seguendo la vocazione salesiana, si dedicò alla cura dei giovani. In Via Coda Rimessa c’era un Oratorio ormai chiuso da tempo. Era la Chiesa di San Filippo, fatta costruire da un Guarnacci ai primi del ’600. Il luogo allora (ed anche oggi) apparteneva alla centuria di San Filippo. Nel passato aveva svolto una funzione particolarmente interessante e che sarebbe bene che qualcuno, un giorno, illustrasse più ampiamente. Vi si erano svolte delle veglie sacre con accompagnamento musicale. Il Maestro volterrano Annibale Cinci, benemerito anche in altri campi per i suoi studi di storia locale, vi aveva tenuto un Oratorio festivo ed una scuola per i giovani più poveri della città, nella prima metà dell’Ottocento. La Chiesa era piena di polvere e dimenticata ed intristiva in un semi abbandono. Don Pedussia, con l’appoggio del vescovo, l’aprì per istituirvi un Oratorio festivo che durò fino al dopo guerra quando l’ambiente e la Chiesa furono distrutti nelle strutture interne e tutto fu ridotto ad un magazzino della P.O.A. (quanti delitti si sono compiuti e si compiono ancora oggi in nome del… bene!).
I POCHI AMICI
Accanto all’Oratorio, che divenne una comunità giovanile singolare e mai più ricostruita in Volterra, sorsero i Cooperatori e le Cooperatrici salesiani; frequentemente si riunirono nella Chiesa padri e madri di ragazzi di tutta la città. Fu questo uno dei meriti più grandi di Don Pedussia. Dopo di lui, mai più, nonostante altri generosi tentativi, fu possibile riunire insieme i ragazzi della città in una esperienza comunitaria così viva. Certo Don Pedussia ebbe sempre costante, determinante l’appoggio dell’autorità del vescovo Munerati. E di un aiuto così autorevole c’era veramente bisogno perché gelosie, incomprensioni, invidie, sospetti ed anche peggio accompagnarono il generoso lavoro di Don Pedussia. Pochissimi furono i sacerdoti che lo capirono, che lo aiutarono. Io ricordo soltanto Don Cavagnera, padre spirituale del Seminario, il canonico Bellini, i seminaristi del Seminario vescovile che tenevano le varie classi di catechismo ed alcune suore dell’Istituto San Giuseppe e, fra tutte, l’infaticabile suor Concetta. Sporadicamente appariva qualche altro sacerdote (Don Mancini), ma per il resto fu gelo e freddezza.
Si brontolava che in quella vecchia Chiesa, quella masnada di ragazzi e ragazze, prima o poi, avrebbero spaccato tutto (si vide bene invece, chi, nel dopoguerra, avrebbe spaccato tutto). Poi non si riusciva a capire perché tutti quei ragazzi e quei giovani, al suono della campanella dell’Oratorio, giungessero da tutta la città ad affollare, contenti, la vasta Chiesa, disertando le Messe e le chiese parrocchiali. Eppure di ragioni ce n’erano parecchie e neanche difficili a capirsi.
UNA MESSA COMPRENSIBILE
La riforma liturgica era allora nella mente di Dio, ma la Messa dell’Oratorio non era così noiosa ed incomprensibile come le altre Messe. Qui si cantava in italiano ed in latino dal principio alla fine. C’era un piccolo armonium che riempiva di musica la Chiesa: c’erano gli assolo dei ragazzi e delle ragazze più vocalmente dotati. C’era una realtà: era la Messa per giovani.
La Messa era solo uno degli aspetti delle tante attività di quella comunità giovanile; c’era anche una intuizione di Don Pedussia: non si è mai vista un’anima disincarnata dal corpo e lui pensava anche al corpo. In quei tempi di miseria, dopo la Messa, si distribuiva, a tutti i presenti, una pasta, un panino, un sacchetto di caramelle; c’erano le gare di catechismo con le premiazioni finali (libri, scarpe, pezze di stoffa per cucire vestiti, giocattoli), c’erano le gite, c’era la fanfara, c’era tanta allegria e tanta giovinezza. Anche perché Don Pedussia aveva capito queste cose, i giovani gli volevano bene. La festa di San Giovanni Bosco era celebrata in maniera eccezionale come mai a Volterra è stato celebrato nessun altro santo. Le vie della zona vicino a San Filippo erano parate con festoni, con lampioncini che a sera venivano accesi: la Chiesa risplendeva di luce, c’era una processione per tutti i vicoli del luogo. Tutti gli abitanti si sentivano partecipi ed erano contenti per l’attività svolta da quel prete sempre allegro e sorridente che parlava in maniera così diversa dai toscani. Anche gli alabastrai della zona, liberi pensatori, emarginati dal fascismo, guardavano con curiosità e con un certa simpatia quel prete e permettevano che i loro figli frequentassero l’Oratorio.
L’attività dell’Oratorio era iniziata il 10 agosto del 1925; gli iscritti erano già centocinquanta. Nel 1926-27 ci fu una crisi di presenze per contrasti ed incomprensioni. Don Pedussia, che era molto stanco, prese un periodo di vacanza. Quando ritornò trovò solo un piccolo gruppo di ragazzi che lo aspettavano con ansia. Egli era scoraggiato e forse, se i ragazzi presenti non avessero insistito, si sarebbe arreso. Da “Voce giovanile”, un foglietto poligrafato che cominciò ad uscire nel 1933 (a cura di Enzo Fivizzoli, Dino Bulleri e pochi altri) abbiamo ricavato queste notizie. Dalla preziosa pubblicazione risulta che, negli anni seguenti, gli iscritti all’Oratorio raggiunsero quasi le trecento unità, con una media oscillante approssimativamente sulle duecentocinquanta.
FRA I CATTOLICI VOLTERRANI NEI BURRASCOSI ANNI TRENTA
Gli anni in cui sorse l’Oratorio erano difficili: lo stato liberale si avviava al tramonto; già da due anni il fascismo era al potere. Con il 1925 iniziava lo stato totalitario; con il 1926 venivano soppressi i partiti e tutte le libere associazioni, perfino i boyscouts. Nel 1931, anche dopo i Patti Lateranensi, ci fu lo scontro con l’Azione Cattolica, che fu sul punto di essere sciolta. Il fascismo non poteva vedere, certo di buon occhio, l’attività svolta da quel prete piemontese.
Don Pedussia fu di una pazienza e di una abilità diplomatica non comuni. Le adunate fasciste della domenica mattina sconvolgevano il suo lavoro pastorale, ma lui non si poteva ribellare apertamente. I ragazzi dell’Oratorio erano “quelli di Don Pedussia”: venivano presi in giro con argomenti pesanti nei locali pubblici, accompagnati dal canto di “A Don Bosco, al padre santo… ” intonato sardonicamente e con allusioni volgari. Anche nelle adunate del sabato fascista, in genere, non avevano vita facile, specialmente se erano iscritti anche all’Azione Cattolica San Giovanni Bosco. Poveri pomeriggi del sabato, sciupati nel non far niente, nel marciare assurdamente in su ed in giù nell’orto dell’asilo infantile, all’interno dei locali dell’Opera Nazionale Balilla (e poi Gioventù Italiana del Littorio) di Via San Lino! Il turpiloquio, la bestemmia, le canzoni sguaiate ed irriverenti erano la cosa più normale, mentre capimanipoli, ufficialetti e dirigenti infrusciaccati, pettoruti, saputelli e boriosi facevano la gara a mettere in vetrina i ritrovati suggeriti dai Fogli d’Ordine della Direzione centrale del Partito Nazionale Fascista. Giravano, abbaiavano ordini e contrordini o lasciavano i ragazzi nell’inerzia mentale e ideologica più assoluta. Non si imparava niente di buono.
Don Pedussia, ad un certo punto, chiese di fare il cappellano della G.I.L. e tentò, per qualche sabato, di svolgere delle lezioni di religione, insieme ad altri che cercavano di impartire un insegnamento qualsiasi, per far cessare quella specie di bolgia. Ma il tentativo durò poco. Si accorse presto che in quell’ambiente ogni fatica era inutile. Forse fece quell’esperienza per far cessare l’ostilità di alcuni sacerdoti notoriamente fascisti, forse per impedire più gravi limitazioni al suo Oratorio. Qualcuno, più tardi, lo accusò di filofascismo. Niente di più assurdo ed inesatto. Se negli ambienti cattolici volterrani ci fu qualcuno che, anche durante gli anni 1935-1936 quando il fascismo era all’apogeo, fece delle critiche al regime, questo avvenne negli ambienti dei ragazzi più grandi di Don Pedussia.
Verso la fine degli anni Trenta fu arrestato a Torino Aldo Pedussia, nipote di Don Luigi. È questa una pagina che non molti a Volterra conoscono e che è bene qui ricordare. Rammento i pianti ed il dolore del buon prete quando giunse la notizia dell’arresto e della condanna da parte del Tribunale Speciale Fascista. Aldo Pedussia, fin dagli anni dell’università, fu uno dei capi, anzi il più attivo, del movimento Giustizia e Libertà in Piemonte. Ne ha parlato recentemente anche Guido Calogero nel corso di una trasmissione televisiva dedicata ai protagonisti della lotta antifascista (lunedì 9 settembre 1974). Tra i documenti (esposti anche a Volterra al Palazzo dei Priori) della Mostra dell’Antifascismo e della Resistenza itinerante per tutta l’Italia, erano riprodotte anche alcune lettere di Aldo Pedussia ai suoi cari, in cui si parlava di “zio Luigi”.
Aldo Pedussia era allora rinchiuso nel carcere di San Gimignano per scontarvi una dura condanna inflittagli per la sua attività antifascista tra i giovani e gli intellettuali. Don Luigi, come risultava anche da quelle lettere, cercava di alleviare la prigionia del nipote inviandogli libri di ogni genere, molti editi dalla S.E.I., editrice salesiana, che poteva avere a buon prezzo. Ma la Direzione del carcere, forse su ordini dall’alto, forse perché impensierita dal fatto che il detenuto Aldo Pedussia leggesse libri di filosofia, di teologia, di economia e classici di ogni genere, non li passava al condannato che, nelle lettere ai familiari, alludeva sempre con una certa ironia a questi libri di cui lo zio gli parlava nelle sue lettere e che non arrivavano mai. Aldo Pedussia fu, una volta liberato dal carcere nel 1943, valoroso comandante partigiano in Piemonte nelle Brigate Giustizia e Libertà.
ESPERIENZE PASTORALI
Il lungo episcopato di Monsignor Munerati fu molto importante per Volterra. Precedentemente, sotto Monsignor Mignone, si era fondato un settimanale cattolico, “La Scintilla”, vera e propria spina nel fianco del predominio liberale e monarchico che, infatti, sulle pagine de “Il Corazziere” non tardò a scatenarsi con una serie di attacchi e di polemiche. Con Munerati fu fondato “L’Araldo” le cui alterne e burrascose vicende sono state rievocate di recente su queste colonne.
Penso che molto dei metodi pastorali di quel tempo sia dipeso da Don Pedussia. Tutto e niente fu rivoluzionario nel suo insegnamento pastorale. Niente di eccezionale rispetto al livello medio italiano del tempo, quasi tutto di nuovo rispetto al livello cittadino e diocesano.
Egli si servì di mezzi tradizionali quale il teatrino dei burattini, il cinema muto a passo ridotto (imparammo ad amare Charlot, Ridolini e gli altri eroi della risata proprio allora), la biblioteca con i libri di Ugo Mioni (caro eroe Braccioforte), della “Pro Famiglia”, di “Letture Cattoliche”, i tornei di ping-pong, eccetera. C’era però una grossa novità: tutto era gestito, amministrato, curato, organizzato dai ragazzi più grandi dell’Oratorio. Lui tirava fuori i soldi, talvolta in maniera che a noi sembrava miracolosa. E poi venne la fanfara con la sua scuola di musica. I ragazzi non stavano mai in ozio, si giocava a pallone, si organizzavano gite, si effettuava la vendita di diecine e diecine di copie de “L’Araldo”, di “Crociata Missionaria”, di “Pro Famiglia” e di tante altre pubblicazioni. Nessuno si tirava indietro, ma nessuno era forzato a fare se non se la sentiva. L’Oratorio era come un porto di mare. Tanti approdavano e venivano accolti festosamente; c’era chi continuava a venire, chi spariva e riappariva dopo qualche tempo e chi non ritornava più. A tutti Don Pedussia dava la sua fiducia, a tutti concedeva qualche minuto del suo tempo prezioso per parlare di tutto. Era onnipresente, dava consigli, esortazioni, ma lasciava una grande libertà. Nessuno doveva fare qualcosa senza entusiasmo, senza convinzione.
Ricordo di essere stato richiamato diverse volte perché “ponevo troppe domande”, sollevavo parecchi dubbi ad alcuni seminaristi della scuola di catechismo, ed essi si erano lamentati con lui. Fece quelle osservazioni con grande pazienza, sorridendo con comprensione e finendo col dire che non c’era niente di male ma che, forse, talvolta potevo farlo mettendo in imbarazzo qualcuno: anche i seminaristi, in fondo, non erano che degli studenti un poco più grandi di noi.
Riusciva a realizzare un clima fraterno, di reciproco aiuto, di amicizia: chi è stato amico all’Oratorio, anche se la vita ha imposto dispersioni, divisioni, ha conservato una parte di quel prezioso patrimonio.
“L’Araldo” gli portava via tanto tempo; il vescovo spesso si serviva di lui per tirare le orecchie ai preti della diocesi che lo temevano e lo vedevano come un’eminenza grigia che spingeva il vescovo buono ad essere cattivo con loro.
Era un santo allora? Era perfetto? Non credo. Aveva certamente anche lui i suoi difetti, probabilmente commetteva anche lui i suoi errori ma era, secondo noi ragazzi dell’Oratorio, un vero uomo di Dio: e così ci appare anche ora a distanza di tanti anni.
Non ricordo di averlo mai visto veramente arrabbiato. Addolorato, stanco, perplesso sì, ma mai adirato con qualcuno. Certo era diverso da noi toscani. La sua stirpe contadina piemontese era
rimasta inalterata. Fino agli ultimi anni di vita, trascorsi nella casa salesiana di Colle Val d’Elsa, fu attivo, umile, instancabile: un vero contadino nella vigna del Signore che non si smarrisce se il raccolto non è buono, che non si dispera se le avversità atmosferiche imperversano; pronto sempre a ricominciare daccapo con spirito giovanile fino all’ultimo respiro.
Ed ora chiudiamo questi ricordi che non vogliono essere affatto un’agiografia, non pretendono di essere stati esaurienti perché molto ancora si potrebbe dire sull’Oratorio di San Filippo e molti altri potrebbero dire di più. Queste righe volevano essere un contributo a quella storia locale che, nell’ambito del movimento cattolico, mi sembra essere un poco scarsina di notizie. Se tutti quelli che hanno documenti, ricordi, aneddoti li tirassero fuori, in qualche modo forse si salverebbero notizie preziose per gli storici del domani.
Non sembri un’esagerazione: la storia non è fatta solo di documenti ufficiali, ma anche di diari, di riflessioni, di umori, di impressioni, di esperienze di persone o di gruppi. E tutto questo può avere un riflesso anche nella storia di più ampio respiro. Nella tomba è bello non portare niente: neppure i ricordi. Se non possiamo lasciare un’eredità di beni economici, sforziamoci, almeno, di lasciare, a chi viene dopo di noi, un’eredità di affetti: qualunque sia l’uso che ne vorranno fare i nostri nipoti.
